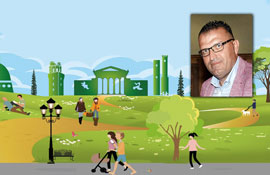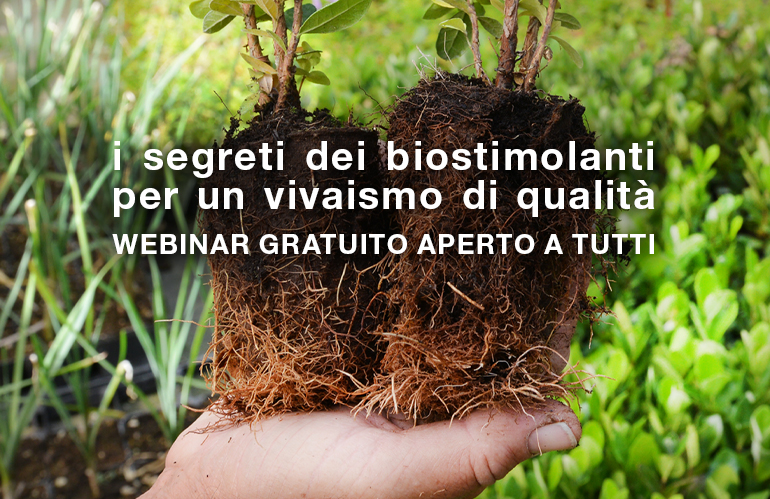Il vivaista
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Confagricoltura ha reso noto che l’indagine preliminare del gruppo di valutazione del glifosato incaricato dalla Commissione europea non prevede «una modifica alla classificazione esistente». Giansanti: «confidiamo che il prosieguo delle valutazioni sia ispirato dal massimo rigore per la piena tutela di tutte le parti in causa, a partire dai consumatori».
«Il glifosato non è cancerogeno, mutageno e tossico per la riproduzione. Ci sono, quindi, le condizioni per prolungare l’autorizzazione all’uso del prodotto, anche se servono ulteriori analisi in merito all’impatto sulla biodiversità».
Sono le conclusioni, segnalate nei giorni scorsi da Confagricoltura, del rapporto preliminare, redatto su mandato della Commissione europea, dalle autorità di quattro Stati membri - Francia, Paesi Bassi, Svezia e Ungheria - che è stato trasmesso all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
In una nota ufficiale diffusa il 15 giugno, l’EFSA ha evidenziato che le autorità dei quattro stati membri, non hanno previsto «una modifica alla classificazione esistente» del glifosato.
«Prendiamo atto del parere preliminare – ha dichiarato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - Siamo solo al primo passaggio di una lunga e accurata procedura che si concluderà l’anno prossimo. Confidiamo che il prosieguo delle valutazioni, fino alla decisione finale, sia esclusivamente ispirato dal massimo rigore per la piena tutela di tutte le parti in causa, a partire dai consumatori».
Il parere preliminare sarà oggetto, a partire da settembre, di consultazioni aperte al pubblico a cura dell’EFSA e della ECHA. A seguire, la classificazione del glifosato sarà portata all’esame del Comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia per le sostanze chimiche. Infine, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare effettuerà una revisione conclusiva che sarà resa nota nella seconda metà dell’anno venturo.
Terminata la procedura, sarà la Commissione europea a presentare la proposta per l’eventuale rinnovo dell’autorizzazione all’uso del glifosato. L’attuale autorizzazione quinquennale scadrà il 15 dicembre 2022.
«Occorre comunque rilevare che gli agricoltori italiani fanno un ricorso limitato al glifosato, utilizzato solo nelle fasi di presemina. Al di là di quelle che saranno le scelte della Ue, – conclude il presidente di Confagricoltura - la transizione ecologica impone la diffusione di processi produttivi più sostenibili e una minore pressione sulle risorse naturali».
Redazione
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Nella prima tappa bolognese del progetto VerdeCittà manifestata da più voci (Ferretti del Conaf, Diolaiti dell’Ass. pubblici giardini, Magazzini dell’Ass. vivaisti italiani) l'esigenza di “contratti di produzione” (o coltivazione) per far fronte all’aumento della domanda di piante legato al contrasto al cambiamento climatico e alla mitigazione dei suoi effetti. Magazzini ha chiesto anche un'equiparazione del vivaismo ornamentale all’agroalimentare sui principi attivi utilizzabili per la difesa dai patogeni.
«Ormai anche la politica ha fatto propria l’idea che il verde è utile e sfogliando i quotidiani vediamo un continuo annuncio di numeri incredibili di piante. Ma ci vuole qualcuno che sia in grado di produrre verde di qualità. Per fortuna in Italia siamo al top in Europa per la produzione di verde. Ma non sono tutte rose e fiori perché, come ha accennato Renato Ferretti nel suo intervento, molte piante hanno bisogno di 10 anni di produzione. Per cui senza programmare la produzione si ragiona del nulla, abbiamo una capacità produttiva limitata e questa primavera abbiamo avuto difficoltà a soddisfare tutta la domanda».
Così il presidente dell’Associazione vivaisti italiani (Avi) Luca Magazzini, nel suo intervento conclusivo del webinar di VerdeCittà Bologna dello scorso 11 giugno, ha sottolineato l’importanza della programmazione della produzione di piante dei vivai, possibilmente con contratti di coltivazione o di produzione pluriennali, per far fronte all’aumento della domanda di verde legato al contrasto al cambiamento climatico e alla mitigazione dei suoi effetti. Argomento toccato anche da altri relatori del primo dei cinque webinar di VerdeCittà, uno su argomento diverso per ognuna delle cinque città coinvolte nel progetto a cura di Mipaaf-Crea, Fiera di Padova e Conaf (vedi), che verteva proprio su verde e climate change.
«Nella gamma produttiva abbiamo migliaia di varietà di piante e forme per i più vari utilizzi – ha aggiunto Luca Magazzini - però tutte queste produzioni si scontrano con problematiche fitosanitarie in divenire per l’aumento incredibile delle minacce di patogeni. Non per nostra incompetenza, ma perché negli ultimi 20/25 anni con la globalizzazione delle merci (non solo delle piante) sono arrivati patogeni alieni che prima non esistevano e che dobbiamo combattere con principi attivi più che dimezzati perché il sistema normativo li ha penalizzati. Per cui ogni stagione abbiamo meno principi per difendere le piante da più minacce». «Pertanto – ha concluso Magazzini - chiediamo da un lato contratti di produzione per programmare le coltivazioni dei vivai e dall’altro un rafforzamento dei principi attivi a disposizione per difendere le produzioni. A questo proposito, un suggerimento già avanzato da tempo è quello di poter utilizzare principi attivi che sono utilizzati nell’agroalimentare (il comparto in cui si producono, a differenza nostra, prodotti che vanno sulle tavole dei cittadini) anche nel vivaismo ornamentale». Niente di più che una equiparazione al resto del settore agricolo, dunque.
Il webinar si era aperto con il saluto di Pietro Gasparri del Ministero delle politiche agricole e forestali (Mipaaf) che ha ricordato che il progetto VerdeCittà è nato nel contesto delle attività del tavolo di filiera del florovivaismo e mira tra l’altro a divulgare la qualità delle produzioni vivaistiche nazionali in particolare fra le amministrazioni pubbliche. «Vogliamo valorizzare il prodotto nazionale – ha detto Gasparri – ma vogliamo anche incoraggiare investimenti nel verde pubblico e nella sua manutenzione», per tutti gli effetti benefici che esso ha sulla qualità della vita nelle città.
Subito dopo Gianluca Burchi, dirigente del Crea OF che ha coordinato il progetto VerdeCittà, ha elogiato l’allestimento di piante di questa prima tappa bolognese, che è stato curato da Riccardo Adversi con 13 specie arboree e 290 specie arbustive scelte tenendo conto anche delle capacità di catturare le emissioni inquinanti, e poi ha messo in evidenza il coinvolgimento di tutti i segmenti della filiera nell’ambito del progetto. «Il verde è un investimento: non una spesa – ha rimarcato Burchi -. Come mostrano vari studi, ogni euro investito nel verde alla lunga porta un vantaggio sicuramente superiore all’euro investito».
Renato Ferretti, consigliere del Consiglio nazionale dell’ordine degli agronomi e dei dottori forestali (Conaf) e coordinatore scientifico di VerdeCittà, dopo aver ringraziato per il contributo al progetto Alberto Manzo, funzionario del Mipaaf a lungo coordinatore del tavolo di filiera, e Cristiana Bertero di Flormart, ha così riassunto gli obiettivi generali: qualificare il verde delle città, aumentare le superfici a verde e gli alberi, migliorare la gestione del verde. Poi, dopo aver perorato la causa dell’uso di una «terminologia corretta», ha fra l’altro detto che la domanda di verde delle città si articola nelle seguenti esigenze: mitigazione degli estremi climatici, creazione di una rete ecologica urbana, contrasto alle allergie ma anche piante pollinifere per favorire gli insetti pronubi, alberi adatti ad ambienti e usi diversi. «Le risposte – ha sostenuto Ferretti - vengono dalla produzione, che deve essere preparata per questi usi e ha bisogno di una programmazione, perché non si possono improvvisare gli alberi. Per avere buoni alberi, devono essere allevati 10/12 anni in vivaio. Bisogna che i produttori abbiano un programma pluriennale su cui contare e non si può mettere tutto a gara. Solo così potremo fare progetti contestualizzati, con la scelta delle specie adatte, ma anche le indicazioni agronomiche per le migliori condizioni di impianto e il programma delle cure colturali per il primo quinquennio».
Nella sua relazione su “Verde e microclima urbano”, il prof. Simone Orlandini del Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali e del Centro interdipartimentale di Bioclimatologia dell’Università di Firenze, ha illustrato le molteplici relazioni fra la presenza di vegetazione e il clima nelle città, guardando a temperatura, vento e umidità. Con particolare attenzione al fenomeno dell’isola di calore urbana, per cui fra città e ambiti extraurbani si arriva a differenze di temperatura anche di oltre 5 gradi, che ha effetti negativi sulla salute e incentiva l’uso dei condizionatori d’aria, i cui motori contribuiscono a loro volta ad aumentare la temperatura e l’inquinamento atmosferico in un vero e proprio circolo vizioso. Il professore ha poi spiegato come si estrinseca l’azione mitigatrice della vegetazione fornendo alcuni esempi e anche raffronti sui diversi effetti di differenti tipologie di aree verdi e piante.
“Il verde in città contro il cambiamento climatico: la gestione della ‘foresta urbana’” è stato il tema dell’intervento di Roberto Diolaiti, presidente dell’Associazione pubblici giardini e direttore del settore Ambiente e verde del Comune di Bologna. Facendo riferimento all’aumento della frequenza degli eventi naturali calamitosi negli ultimi anni, Diolaiti ha prima messo in chiaro che non si può più parlare di eventi meteorologici “estremi” ma bisogna usare il termine eventi meteo “non convenzionali”. Poi ha riassunto i fattori critici nella gestione degli alberi in ambienti urbani (spazio vitale, interferenze spaziali, inquinamento ambientale, danneggiamenti) e i principi della coltivazione della foresta urbana. «Bologna con il progetto Blueap è stata la prima a dotarsi nel 2015 di un piano di adattamento al cambiamento climatico – ha detto Diolaiti – e molte delle azioni lì previste vedono gli alberi come protagonisti». Gli alberi e le piante in generale sono dunque i «migliori alleati dell’uomo» in questa battaglia. Ma come sceglierli? «La ricerca scientifica – ha puntualizzato Diolaiti – ci ha restituito risultanze in relazione all’efficacia ed efficienza di alcune specie botaniche rispetto ad altre. Ma anche in termini di emissione di sostanze volatili, di potenzialità allergenica e di propensione alla formazione di ozono». Quindi occorre piantare sempre più alberi delle specie botaniche più efficaci e meno esigenti, dando corso anche ai rinnovi dei patrimoni arborei senescenti, che sono meno efficaci nell’ottica del contrasto ai cambiamenti climatici. Ma se non vogliamo correre il rischio di «non riuscire a reperire il necessario materiale vegetale (o, quanto meno, della qualità richiesta)» sono necessari «i “contratti di coltivazione”, ossia rapporti pluriennali tra amministrazioni pubbliche e produttori, finalizzati ad avere garanzie sulla fornitura del materiale vegetale necessario, quanto meno nell’ambito della corretta gestione della “foresta urbana”».
L.S.
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Il progetto del Mipaaf-Crea e di Fiera di Padova “VerdeCittà”, che coinvolge 5 capoluoghi di regione italiani e promuove ambienti urbani sempre più green e sostenibili, sarà presentato alle ore 11 dell’8 giugno in diretta streaming sul canale Youtube del Crea.
«Bellezza, salute e benessere. Ma anche pianificazione scientifica e corretta gestione». Così viene presentato dagli organizzatori “VerdeCittà”, il progetto finanziato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), coordinato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea) e organizzato dalla Fiera di Padova con il supporto scientifico del Consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali (Conaf), per sensibilizzare l’opinione pubblica sia sull’importanza e sui benefici dell’inserimento di piante e della loro cura nel contesto urbano sia sull’eccellenza del florovivaismo made in Italy. Con l’intento di creare una vera e propria “cultura del verde”, 5 piazze, in 5 città italiane, Bologna, Palermo, Roma, Torino e Padova, tra giugno e settembre, saranno trasformate all’insegna del verde dagli esperti agronomi del Conaf, in collaborazione con i Comuni. Interventi realizzati su misura delle città ospitanti e coniugando la bellezza della natura con le ultime evidenze scientifiche in materia di salute e sostenibilità.
Con l’intento di creare una vera e propria “cultura del verde”, 5 piazze, in 5 città italiane, Bologna, Palermo, Roma, Torino e Padova, tra giugno e settembre, saranno trasformate all’insegna del verde dagli esperti agronomi del Conaf, in collaborazione con i Comuni. Interventi realizzati su misura delle città ospitanti e coniugando la bellezza della natura con le ultime evidenze scientifiche in materia di salute e sostenibilità.
Di tutto questo si parla oggi 8 giugno, a partire dalle ore 11, nell’evento in diretta streaming di presentazione del progetto. Un appuntamento a cui interverranno fra gli altri, il presidente del Crea Carlo Gaudio, la presidente del Conaf Sabrina Diamanti, il presidente della Commissione Agricoltura del Senato Giampaolo Vallardi e il presidente della Commissione Agricoltura della Camera Filippo Gallinella. Introdurranno il progetto Pietro Gasparri, Dirigente Ufficio DPQAI II - Mipaaf - Aggregazione, piani di settore e agroenergie, e Gianluca Burchi, dirigente di ricerca del Crea Orticoltura e Florovivaismo che coordina VerdeCittà, mentre Renato Ferretti, consigliere del Conaf e coordinatore scientifico del programma culturale, farà una panoramica del verde urbano in Italia. Infine, città per città, un esponente del Comune e un esperto del Conaf illustreranno i giardini che saranno realizzati.
Per seguire l’evento collegarsi al canale Youtube del CREA.
Redazione
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
I progetti urbanistici e architettonici di Prato, improntati alla circolarità economica e al riuso, all’inclusione sociale e la multiculturalità, alla sostenibilità ambientale e la forestazione, sono in primo piano nella 17^ Biennale di architettura di Venezia, che è stata inaugurata nei giorni scorsi e resterà aperta fino al 21 novembre 2021. Per la precisione vengono esposti nel contesto della mostra “Comunità Resilienti” in corso al Padiglione Italia. Si tratta di oltre cinquanta progetti nati o promossi dalla città di Prato e raccontati nell’installazione multimediale “Città natura, città fabbrica, città paesi”. Fra i soggetti protagonisti della partecipazione pratese alla Biennale di architettura 2021 il progetto Prato Urban Jungle, a cui collabora anche l’Associazione Vivaisti Italiani.
Redazione
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
L’11 giugno webinar a libero accesso organizzato da Confagricoltura Pistoia e Cifo sul tema dell’uso dei biostimolanti nel vivaismo ornamentale per migliorare la salute e qualità delle piante. Seguirà il 18 giugno un altro webinar sull’uso dei biostimolanti in olivicoltura e viticoltura.
“L’impiego dei biostimolanti nel vivaismo ornamentale per la salute e buona formazione delle piante - centralità del controllo dei marciumi dell’apparato radicale”.
Redazione
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
L.S.