Vis-à-vis
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
L’assessore all’urbanistica e ambiente del Comune di Prato Valerio Barberis, sentito al Memorial Vannucci dopo l’intervento di Stefano Boeri, illustra con alcuni esempi di “Prato Urban Jungle” l’approccio alle sempre più necessarie forestazioni urbane del grande architetto milanese e in particolare il senso dei “tetti verdi”. Barberis è favorevole ai contratti di coltivazione per favorire la programmazione delle forniture di piante dei vivaisti (anche con formule innovative su aree pubbliche).
«Un excursus su quello che è stato un suo percorso che di fatto è stato anche un percorso internazionale sull’attenzione che oggi si pone ai temi del verde e della natura. Perché il bosco verticale, come poi ha detto, è diventato un’icona, un manifesto di un movimento».
L.S.
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Il presidente del Distretto vivaistico di Pistoia Francesco Ferrini, intervistato al Memorial Vannucci del 2 ottobre, si è mostrato aperto a vari tipi di interventi (dalle forestazioni alle pareti e i tetti verdi), purché sia garantita la «qualità del materiale vegetale». Ma gli obiettivi sui numeri di alberi da piantare devono essere più realistici e rapportati alle quantità di piante disponibili nei vivai italiani (compresi quelli forestali): «intorno a 10 milioni all’anno».
Sabato scorso al Nursery Campus di Pistoia, in occasione del 22° Memorial Vannucci in cui è stato premiato l’architetto Stefano Boeri, celebre per i suoi boschi verticali o grattacieli verdi, era presente anche il prof. Francesco Ferrini, presidente del Distretto vivaistico ornamentale di Pistoia e docente di Arboricoltura all’Università di Firenze. Floraviva lo ha intervistato ponendogli qualche domanda a partire dagli spunti offerti dal grande architetto Boeri nella sua conversazione con il giornalista Luca Telese. L’intento era riconsiderare alcune questioni del verde urbano anche da punti di vista differenti da quello dell’architetto: lo sguardo dello studioso di alberi e la prospettiva del vivaista che li produce.
Quali sono le idee più interessanti, dal punto di vista del vivaismo, venute fuori in questo incontro con l’architetto Boeri?
«Io credo che siano state sottolineate due cose fondamentali. Primo, l’importanza delle piante, ma questa credo sia ormai nota a tutti. Secondo, l’importanza della qualità del materiale vegetale che viene poi utilizzato per creare questi meravigliosi grattacieli verdi o boschi verticali e questi tetti verdi. Quindi è emersa prepotentemente questa esigenza, e chiaramente Boeri è una voce importante e se lo dice lui è chiaro che le persone lo ascoltano».
Boeri ha elencato una serie di azioni possibili per incrementare il verde negli spazi urbani. Tra queste, si è soffermato in particolare su un tipo di intervento che sta sempre più prendendo piede, anche se ha delle complicazioni: i cosiddetti tetti verdi. Che cosa ne pensa?
«Questa si è trasformata da una moda a una necessità. Il tetto verde riduce moltissimo l’effetto impermeabilizzazione che si ha dopo un’urbanizzazione. Se noi realizziamo un tetto verde l’acqua che cade viene temporaneamente raccolta, ne viene ridotta la velocità d’impatto. Ovviamente poi il terreno evapora, le piante traspirano, si raffresca l’atmosfera. E soprattutto si è capito l’importanza nella mitigazione degli effetti climatici sia esterni che interni agli edifici».
E lei quale tipo di intervento a verde sottolineerebbe come particolarmente importante, degno di attenzione?
«Più che un tipo di intervento tecnico, io credo che sia importante che questi eventi siano seguiti dalle scuole, come oggi, dalle persone. E che si passi dalle parole all’azione. Ecco, agire, perché se ognuno fa qualcosa, poi chiaramente la massa conta tanto. E su questo purtroppo c’è un problema di scarsa comunicazione e anche scarsa dimestichezza con il verde in genere nel nostro Paese, che, in realtà, è stato il primo a utilizzarlo storicamente. Poi ne abbiamo perso un po’ la memoria. L’esempio del bosco verticale è quasi una mosca bianca in Italia. Tant’è che Boeri ha mostrato grattacieli verdi in tutto il mondo, ma, al momento, non ci sono altri esempi in Italia, se non il progetto del Bosco Navigli che sarà completato nel 2024. Questo mi pare sintomatico».
Una domanda sugli obiettivi delle forestazioni urbane e non, sui numeri di alberi che si progetta di piantare: argomento su cui lei interviene spesso. Tanto per restare a un esempio toccato oggi, l’iniziativa “Forestami” ha un target per l’area metropolitana di Milano di 3 milioni di alberi piantati entro il 2030? Le sembra realizzabile o lei è meno ottimista?
«Più che meno ottimista, io sono realista. Diciamo che di tempo ce ne vuole tanto e ci vogliono le piante che attualmente non sono disponibili e ci vuole anche tanta acqua per far sì che queste piante sopravvivano. Io più che “pianteremo milioni di alberi”, preferirei “faremo sopravvivere la gran parte di quelli che pianteremo” senza dire tanti numeri e soprattutto senza dire numeri tipo, che ne so, per Pistoia 90 mila perché sono 90 mila gli abitanti di Pistoia. Magari Pistoia ha bisogno di 180 mila. Oppure magari Milano, anziché 3 milioni che sono poi gli abitanti della città metropolitana, ne ha bisogno di 6 milioni. Firenze, dico così a caso, potrebbe averne bisogno di metà rispetto al numero degli abitanti. Quindi non credo che sia opportuno dare dati senza che questi siano basati su un calcolo reale basato su metodi scientifici».
Forse però dare questi target ha un valore comunicativo e di incoraggiamento…
«… ha un valore simbolico».
E parlando di Prato, dove stanno facendo interventi sugli edifici già esistenti, come valuta questa sfida: reggeranno le piante oppure succederà come a Firenze dove diverse piante sono morte in poco tempo?
«A Firenze fu fatta all’epoca una soluzione secondo me un pochino complessa, difficile da gestire. Ora a Prato sinceramente non conosco il progetto nel dettaglio. Ma anche una semplice vite americana, un glicine o addirittura l’edera, anche se l’edera è un po’ più invasiva. Ma qualsiasi rampicante fa l’effetto di una parete verticale. Ovviamente costando molto molto meno, una frazione percentuale. Però una bella vite americana, oltre che avere un colore meraviglioso in autunno, si spoglia in inverno e non impedisce quindi ai raggi solari di scaldare la casa e se messa su un telaio che la mantenga distante quei pochi centimetri dal muro per evitare animali, umidità ecc. ecc., fa un servizio ottimo. E questo lo si ritrova nella notte dei tempi, cioè i tetti verdi ce li avevano nel Nord Europa perché servivano per coibentare e mantenere calda la casa in inverno. Quindi hanno anche l’effetto opposto, non solo di raffrescare d’estate ma anche di mantenerla calda in inverno».
Boeri ha sottolineato il rapporto sempre più costante e stretto fra architetti e vivaisti, i fornitori di piante, oggigiorno. Lei tempo fa ha messo in evidenza che con il balzo della domanda di verde adesso mancano le piante per soddisfare tutti i clienti. Le chiedo: mancano determinati tipi di piante più di altre o è un discorso generale?
«Direi che mancano in generale. Mancano soprattutto le piccole piante da esterno, cioè i piccoli alberi o meglio alberi giovani, cioè di piccole dimensioni. Ma, ripeto, mancano un po’ tutte le piante. Il problema è che l’Unione Europea ha il suo target di piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030. Sono già passati quasi 2 anni e di alberi ne sono stati piantati veramente pochi. Tre miliardi significa che la quota dell’Italia, se consideriamo questo parametro in rapporto con la popolazione, visto che adesso siamo scesi a 57 milioni (e l’Unione Europea ha 447 milioni di abitanti), vorrebbe dire che da qui al 2030 dovremmo piantare oltre 380 milioni di alberi (non di arbusti), vale a dire quasi 50 milioni all’anno. Ma attualmente la disponibilità di alberi nei vivai dell’Italia, compresi quelli forestali, è intorno ai 10 milioni all’anno, seppur sia un dato difficile da quantificare in modo preciso».
Cioè 10 milioni di alberi che si possono acquistare ogni anno?
«Sì, di alberi acquistabili annualmente. E da 10 milioni a 50 milioni c’è il rischio che si incominci a importare materiale di scarsa qualità genetica, morfologica e sanitaria dall’estero. E questo andrebbe a detrimento dei risultati, oltre che mettere ulteriormente a rischio di introduzione di parassiti alieni, che sono pericolosissimi, il nostro Paese».
L.S.
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
A colloquio con il senatore Patrizio Giacomo La Pietra, relatore del disegno di legge Liuni “Disciplina del settore florovivaistico”, al termine delle audizioni dei portatori di interesse ed esperti della filiera in Commissione Agricoltura. Tra i ritocchi migliorativi più richiesti, creare sotto tavoli specializzati e sezioni distinte del “Piano nazionale di settore”, vincoli per impedire una proliferazione di distretti e marchi inconsistenti a danno delle imprese già competitive.
«È stato apprezzato da tutti, anche dai senatori, il fatto che sia stato scritto un disegno di legge (ddl) che finalmente dà piena legittimità all’intero settore florovivaistico, perché il testo del ddl Liuni è in sostanza una specie di legge quadro del florovivaismo. Tuttavia, anche se all’inizio del mio incarico di relatore del ddl Liuni trasmesso dalla Camera dei deputati il 6 novembre 2020 mi dicevano di fare alla svelta, poi nel corso delle audizioni è emerso che questo testo ha bisogno di alcuni chiarimenti e miglioramenti e su questi stiamo lavorando».
Inizia così il nostro colloquio telefonico sul ddl Liuni “Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico” con il senatore pistoiese Patrizio Giacomo La Pietra, svoltosi il 14 giugno quando le audizioni dei portatori di interesse ed esperti della filiera florovivaistica presso la Commissione Agricoltura del Senato di cui fa parte sono quasi giunte al termine.
Quali punti sono da migliorare e chiarire meglio?
«Fra gli elementi su cui c’è più condivisione della necessità di miglioramenti posso citare innanzi tutto il fatto che la composizione del tavolo tecnico, all’art. 6, è molto ampia. Conseguentemente si rischia di avere un tavolo molto generico e si rischia di non riuscire a raggiungere delle sintesi efficaci. Tanto più perché il florovivaismo, nel suo complesso, abbraccia esigenze molteplici e diverse: da quelle della floricoltura a quelle del vivaismo orticolo e quelle del vivaismo ornamentale».
Come intendete porre rimedio a questi rischi?
«Un’ipotesi è quella di razionalizzare il tavolo creando anche dei sotto tavoli. Cioè lasciare il tavolo generale, ma creare anche dei tavoli più specifici e specializzati sui vari comparti. Ciò si rifletterebbe anche sull’art. 9, che riguarda il “Piano nazionale del settore florovivaistico”, lo strumento programmatico di riferimento del settore, che potrebbe essere articolato in sezioni distinte per floricoltura, vivaismo ornamentale ecc.».
Altri elementi su cui c’è convergenza di richieste di modifica?
«Mi pare abbastanza comune l’idea che nell’art. 5 sui distretti si debbano prevedere indicazioni alle Regioni per l’eventuale costituzione di nuovi distretti, con parametri su quando e come è possibile istituirli, in relazione al numero di aziende e la loro concentrazione in un dato territorio, al loro radicamento storico e al Pil generato».
Come mai?
«Altrimenti avremmo una proliferazione di distretti che non aiuterebbe a dare valore aggiunto al settore. E lo stesso vale per la questione collegata della creazione di nuovi marchi: bene farlo, ma solo se serve a innalzare l’asticella qualitativa dei prodotti, con disciplinari precisi, senza concessioni a destra e a manca, e salvaguardando i marchi di aziende private che già sono rinomate e vincenti sui mercati internazionali».
Altre questioni?
«C’è il tema della filiera a cui afferiscono molti soggetti di tutti i segmenti. Va bene valorizzarla, ma facendo riferimento all’articolo 2135 e seguenti del Codice Civile in cui è definita l’impresa agricola. Perché questa legge deve aiutare tutta la filiera, ma partendo dalla valorizzazione dell’imprenditore agricolo».
Sull’articolo 16, che ha suscitato diverse perplessità, che dice?
«Molti ci hanno fatto osservazioni sugli articoli n. 14 (Esercizio dell’attività di manutentore del verde), n. 15 (Contratti di coltivazione) e n. 16 (Partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano). L’aspetto critico è che da una parte si vuole valorizzare il manutentore del verde e affidarsi a professionisti del settore per garantire la qualità, ma poi l’articolo 16 dice di incentivare la partecipazione dei cittadini. Sono due elementi un po’ in contraddizione. Su questi tre articoli dovremo intervenire per armonizzarli meglio fra loro tenendo conto di tutte le esigenze. Anche quelle dei Comuni che spesso non hanno fondi per fare la manutenzione. Perché una cosa è spazzare le foglie secche, un’altra è potare».
E sui garden center, i “centri di giardinaggio”?
«Sui garden center è stata posta una questione sulle possibilità di commercializzazione. Secondo me l’articolo 13 è chiaro nella sostanza, ma c’è solo da definire meglio qualche passaggio».
Altri suggerimenti venuti fuori sui media di settore in questi mesi sono stati: un riferimento ai costi dell’energia delle serre, alla formazione scolastica e un maggior coinvolgimento degli altri ministeri, visto l’impatto che ha il verde anche in altri ambiti come ad esempio quello della salute. Che ne pensa?
«Riguardo alle problematiche energetiche, soprattutto delle serre, credo che sia una mancanza che potrebbe essere utilmente colmata, magari con riferimento al nuovo Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Anche la richiesta di un maggiore legame fra preparazione scolastica e mondo del lavoro, attraverso corsi specializzati nel florovivaismo, è da considerare. Sul coinvolgimento degli altri ministeri, in realtà c’è un riferimento sia nell’articolo 6 in cui si parla della composizione del tavolo tecnico di filiera che nell’articolo 8 sul coordinamento permanente di indirizzo del florovivaismo e della green economy. Forse andrà declinato in maniera più chiara».
Insomma, ha concluso il senatore La Pietra, «sono da fare alcune aggiunte di temi mancanti e correzioni per specificare meglio alcuni punti, ma credo che la seconda lettura al Senato possa far emergere un testo non dico perfetto ma sicuramente più rispondente alle aspettative di tutti gli operatori».
L.S.
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
A colloquio con Pietro Barachini, vivaista olivicolo certificato e assaggiatore d’olio di oliva professionale di Pescia, sulle sfaccettature e complessità dei concorsi oleari, a pochi giorni dalle scadenze delle iscrizioni ai premi Solinas (12 febbraio) e il Magnifico (14 febbraio). Con una battuta a margine sull’isolamento dell’Italia nel Coi: «un fallimento diplomatico».
Nei giorni scorsi sul sito web del Consiglio oleicolo internazionale (Coi) è stato pubblicato il regolamento della nuova edizione del Premio alla Qualità Mario Solinas. Questo è probabilmente il concorso internazionale per oli di oliva extravergini più importante al mondo (vedi), sia per il peso dell’organizzazione che lo promuove, il Coi appunto, sia per la considerazione che ha nei siti web d’informazione settoriale. Con ad esempio il primo posto e il punteggio più alto possibile (10) fra i quaranta, selezionatissimi, concorsi su cui si basa – o almeno si è basata nel 2020 - la piattaforma www.evooworldranking.org, che monitora e stila le top ten mondiali dei migliori “evoo” (“extra vergine olive oils” = oli d’oliva extravergini), dei migliori produttori di olio e dei miglior Paesi produttori di ogni anno incrociando i dati dei diversi concorsi.
Il termine ultimo per iscriversi alla nuova edizione del Premio Solinas è il 12 febbraio 2021. Nonostante che il concorso sia intitolato a un rinomato oleologo italiano quale Mario Solinas, che tanto ha contribuito allo sviluppo e promozione dell'analisi sensoriale dell’olio di oliva, all’edizione del 2020 non solo nessun olio di oliva extravergine italiano è stato premiato, ma non ce n’è stato nemmeno uno capace di arrivare in finale. Tuttavia, data la rilevanza di tale premio e visto che la scadenza dell’edizione 2021 si avvicina, abbiamo deciso di prendere spunto da questi fatti per intavolare una conversazione sia sulla vicenda del Premio Solinas che sui premi oleari in generale, sempre più numerosi e ambiti, con Pietro Barachini, vivaista olivicolo di spicco di Pescia già intervistato da Floraviva a maggio 2020 (vedi), che è anche un assaggiatore professionale d’olio d’oliva, come spiegammo in questo servizio, e fa parte dei panel di alcuni concorsi oleari. Fra cui ad esempio il Premio il Magnifico, il cui termine d’iscrizione è stato prorogato al 14 febbraio 2021, con consegna campioni entro il 21 febbraio (vedi). Al punto che può essere considerato, senza esagerazione, un valido rappresentante dell’intera filiera olivicolo-olearia: dalla produzione di piantine d’olivo all’assaggio dell’olio d’oliva in tavola.
Come mai al Premio Solinas 2020 sono stati così poco lusinghieri i risultati degli oli made in Italy, con nessun premio e neanche uno in finale? Non sarà per il fatto che non c’era nessun nome italiano in giuria?
«La qualità degli extra vergine a livello mondiale è aumentata notevolmente, per vari fattori. In primis perché le tecniche di trasformazione (la frangitura) e i frantoi intesi come macchine sono un’eccellenza italiana che si trova ormai in tutto il mondo. Quindi siamo stati noi a innalzare il livello degli oli d’oliva degli altri esportando i macchinari, le tecnologie. E tantissimi oleologi vanno a fare consulenze all’estero, è successo anche a me. E’ un modello che abbiamo esportato».
Quindi gli oli spagnoli, ma anche portoghesi e nord-africani, sono davvero diventati migliori dei nostri?
«No, questo ancora no. Perché noi abbiamo ancora delle varietà autoctone che nel resto del mondo non ci sono, che ci danno qualcosa in più in termini nutraceutici e di gusto. E consideri che, anche se ad esempio una piattaforma come www.evooworldranking.org (che peraltro non è il Vangelo, per quanto autorevole) nella classifica dei migliori oli d’oliva del 2020 inserisce nei primi dieci 8 oli spagnoli, 1 greco e 1 portoghese, con l’olio italiano meglio posizionato al 22° posto, preceduto anche da alcuni oli turchi, e fra le aziende di produzione la prima italiana è 20esima, è vero però che nel ranking dei Paesi colloca l’Italia al primo posto…».
…ma questo “di più” delle nostre varietà di olio non è emerso nei risultati del Solinas: dipende forse dal fatto che gli italiani partecipanti erano pochi?
«In gran parte credo di sì. A quanto ho letto, erano solo 4 su 157 gli oli italiani partecipanti nel 2020. Di spagnoli ce n’erano 77, di portoghesi più di 30 e di nord-africani oltre 30 (di cui più della metà del Marocco e oltre 10 tunisini). Il fatto è che il produttore di oggi si trova davanti una vasta gamma di concorsi nel mondo fra cui scegliere, per cui magari alcuni produttori italiani avranno preferito altri concorsi più congeniali alle loro aziende».
Ha ragione, però, persino un olio cinese è stato premiato?
«Guardi, al di là delle polemiche nazionali, va considerato che ogni concorso, pur accettando gli standard di assaggio del metodo Coi, ha poi però delle sfaccettature nel regolamento che alle volte vanno a favorire determinati valori rispetto ad altri. E ciò dipende anche da che cosa il concorso vuole fare emergere».
In ogni caso, influente o meno sull’esito, come giudica in sé il fatto che non ci fosse nel panel della giuria dell’edizione 2020 nessun nome italiano?
«Non lo so di preciso, ma potrebbe essere l’effetto dell’isolamento degli italiani in seno al Coi avvenuto nel 2019, su cui ha riferito la rivista Teatro Naturale in un articolo del 12 luglio 2019».
E che ne pensa di questo isolamento degli italiani nel Coi?
«Un fallimento, perché si doveva evitare. Dopotutto siamo fondatori del Coi e la nostra tradizione olivicola non ha eguali nel mondo, anche se in questa fase i livelli produttivi sono molto diminuiti e assai inferiori a quelli della Spagna, la leader mondiale. Ma non conta solo la quantità e sul fronte della ricchezza di varietà autoctone e del livello qualitativo, sia dal punto di vista del gusto che dei valori nutraceutici, come dicevo prima, siamo ancora i numeri uno al mondo. Anche se ultimamente la debolezza produttiva e sul piano della diplomazia economica in questo comparto ci stanno forse penalizzando».
Tornando a quello che mi stava dicendo sulle differenze di regolamento nei vari concorsi oleari nonostante una base metodologica comune, mi può spiegare meglio gli elementi comuni e le differenze?
«L’aspetto comune è il metodo di assaggio. In particolare nei concorsi internazionali si usa una giuria di assaggiatori certificati attraverso il metodo di assaggio universale del Coi, che è stato creato negli anni ‘90 anche con il contributo dell’italiano Mario Solinas, un elaiotecnico di Pescara. E’ indispensabile questo metodo, soprattutto quando si invitano assaggiatori di più nazionalità in una giuria, per uniformare le loro valutazioni. Il metodo Coi contiene in particolare una codifica dei valori sensoriali degli extravergini in gara».
Altri elementi comuni?
«In tutti i concorsi di un certo livello c’è la richiesta dell’analisi chimica del campione di olio che viene inviato. E vengono svolte verifiche a campione sui lotti».
E in che cosa consistono invece le differenze dei concorsi?
«I parametri che il concorso adotta oltre al metodo di assaggio. Vale a dire i parametri per la partecipazione e su cui si basano i punteggi e quindi i premi».
Mi può fare un esempio?
«Posso cercare di spiegarlo con un confronto. Ad esempio fra il Premio Solinas, che non conosco direttamente ma di cui si può leggere il regolamento nel sito web ufficiale, e il Premio il Magnifico, che è un premio internazionale toscano, a cui partecipo come assaggiatore. Cominciamo con la quantità minima per partecipare, cioè dal fatto che i campioni di un olio con cui un produttore partecipa a un concorso devono appartenere a un lotto omogeneo di olio di una certa quantità. La nuova edizione del Solinas (2021), ad esempio, richiede che si tratti di un lotto unico di almeno 3.000 litri, sigillato presso l'azienda, mentre per gli oli dell’emisfero australe lo sbarramento è di 1.500 litri».
Che significa? che si escludono i piccoli produttori? O c’è un altro motivo, magari di tipo commerciale?
«Principalmente lo si fa per una questione di rappresentatività del produttore. E' importante per il consumatore sapere che un olio che ha vinto il concorso verrà trovato in commercio. Comunque, ritornando al confronto, nel concorso il Magnifico la soglia minima è invece di 1.000 litri».
E, al di là di questi sbarramenti quantitativi, in quali altri aspetti si possono differenziare i concorsi?
«Un altro elemento che può differenziarli è il modo di codificare i campioni di olio d’oliva che arrivano con l’etichetta dei produttori. In molti concorsi la segreteria, quando li riceve, li rende anonimi, cioè toglie le etichette che li rendono riconoscibili e assegna dei codici per garantire l’anonimato. Nel concorso il Magnifico, dal momento che siamo molto maniacali, aggiungiamo un livello di sicurezza in più. Siccome ci sono varie fasi di assaggi e tappe della selezione, ad ogni nuova fase il Magnifico cambia i codici ai campioni. Per cui anche un assaggiatore non può memorizzare il codice, perché la volta dopo non è più lo stesso».
Altri aspetti ancora?
«I parametri in base ai quali sono decise le ammissioni e le graduatorie. Ad esempio, i parametri del Solinas, a quanto leggo, sono incentrati sull’indicazione del fruttato, che viene diviso in verde e maturo, dividendo il mondo nei due emisferi: la parte nord fruttati verdi e la porzione dell’emisfero si considerano fruttati maturi. Il verde viene diviso in tre categorie: intenso, medio e leggero. Io riesco a entrare nel Solinas se faccio 70 punti nel verde fruttato intenso e medio, se hai 65 nel fruttato verde leggero e 60 nel fruttato maturo… Se non raggiungi certi punteggi non vieni ammesso. Questo è uno sbarramento iniziale di tipo qualitativo».
E’ corretta questa impostazione?
«Sì. L’intensità del fruttato dipende sia dalla varietà che dalla lavorazione. Un intenso che è maggiore di 7 è molto marcato ad esempio…».
… e che cosa caratterizza il Magnifico?
«Intanto fra le nostre caratteristiche c’è che siamo tra i pochi concorsi che quando si fa l’iscrizione bisogna indicare un punto vendita. Per cui se un olio arriva in finale, gli viene fatta in maniera anonima l’analisi degli assaggiatori del panel sull’olio trovato in vendita, per verificare se corrisponde allo stesso campione inviato dal produttore al momento dell’iscrizione».
Solo questa differenza o ci sono altri aspetti da sottolineare per farsi un’idea di come i regolamenti possano incidere sui risultati?
«Nel Magnifico c’è una logica sottostante un po’ diversa rispetto a molti altri concorsi. Premesso che nel Magnifico il punteggio di sbarramento varia ogni anno. Però, oltre a questo, a caratterizzarci è la sezione “Eqoo Ambassador”, l’olimpo dell’olio extra vergine a livello internazionale. Una stella con 80, due con 85, tre con più di 90 punti. La particolarità è che oltre a valutare la bontà dell’olio, si premia anche il rispetto di una carta di valori riguardanti l’azienda con riferimento alla difesa del paesaggio, alla sostenibilità, alla promozione della filiera locale e così via. Sono compresi quindi anche dei valori etici. Questo è il futuro della qualità dell'extravergine di oliva: la futura Pac 2022-2027 si concentra proprio sulla sostenibilità dei prodotti agroalimentari».
Lorenzo Sandiford
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Per l’architetto fiorentino, premiato al Memorial Vannucci Piante 2020, Pistoia è di fronte a un’occasione unica: qui ci sono le fabbriche che producono ossigeno, le piante e il verde, e ora dobbiamo rinaturalizzare le città per contrastare l’avanzare dell’anidride carbonica e delle emissioni inquinanti. La committenza pubblica inizia a capire e svegliarsi, ma a «una velocità che non è paragonabile all’emergenza» e «alla velocità con cui si sciolgono i ghiacci», mentre gli urbanisti sono dal punto di vista scientifico «prontissimi da decenni» alla svolta. L’esempio delle sue cantine per Antinori a Bargino come costruzione dove «artificio e natura si compenetrano». E ai produttori di piante dice: «se io fossi un vivaista, spenderei parte dell’energia per costruire un cambio culturale che permetta a ciò che produco di essere utilizzato».
Uno dei premiati al Memorial Vannucci Piante 2020, sabato scorso al Nursery Campus di Pistoia, era Marco Casamonti, affermatissimo architetto fiorentino con cattedra di professore ordinario di Progettazione architettonica urbana e del paesaggio all’Università di Genova. Nome ultimamente salito alla ribalta, insieme al collega e amico Massimiliano Fuksas, a cui si deve la prima idea, per la lettera inviata lo scorso aprile, verso la fine della fase di lockdown più dura, al presidente della repubblica Sergio Mattarella: sulla necessità di ripensare il patrimonio abitativo italiano e alcune linee guida su come farlo; vale a dire, in estrema sintesi, case con qualche metro quadrato in più, spazi per lo smart working, collegamenti alle strutture sanitarie per la telemedicina, luoghi per la consegna merci di Amazon ecc., insomma case in cui poter abitare e non solo dormire. Argomenti toccati da Casamonti anche sabato scorso nella conversazione con Luca Telese davanti agli ospiti del Memorial Vannucci, subito dopo Cottarelli.
A un certo punto Telese gli ha detto: «il verde fatica a entrare nella testa di chi fa le case e di chi le compra, come se fosse solo un ornamento secondario», come mai accade questo, almeno a livello di massa? «Il limite è culturale – ha risposto Casamonti - siamo abituati a dividere il mondo in campagna e città. Anche se non è più così, perché ormai sono fuse. Basti pensare alla via emiliana da Bologna a Milano». «Dobbiamo portare la campagna nelle città – ha aggiunto – e pensare alle città come luoghi del verde. Io sono geloso di una città come Pistoia, perché qui ci sono le fabbriche che producono ossigeno, producono piante e verde, e si trova in una occasione storica unica. Qui c’è la manifattura più avanzata del mondo».
Floraviva ha intervistato l’architetto Casamonti, al termine dell’incontro, ripartendo proprio da queste affermazioni e cercando di approfondirle anche dal punto di vista degli operatori della filiera del verde.
Lei ha parlato di occasione storica per Pistoia, perché mai come in questo momento c’è bisogno di verde e i vivai di Pistoia lo producono, ecco può spiegare meglio in che senso ritiene il vivaismo la “manifattura del futuro”.
«Ho detto e ritengo che Pistoia è in questo momento la città con la produzione più avanzata al mondo, perché se la Silicon Valley è il luogo del futuro e della tecnologia digitale, beh Pistoia è il luogo della produzione dell’ossigeno, delle piante, del verde e non ha niente da invidiare alla Silicon Valley. Ci sono in questo momento infatti due elementi trainanti nell’economia del mondo: uno è la digitalizzazione del nostro sistema di vita, l’altro è che dobbiamo rinaturalizzare ciò che negli ultimi 100 anni abbiamo distrutto e quindi dobbiamo tornare a produrre ossigeno e a contrastare l’anidride carbonica che avanza e le emissioni inquinanti. E questo lo possiamo fare con un’industria avanzata che lavora nel verde e produce piante. Pistoia si trova storicamente in questa fase all’apice di una produzione di interesse mondiale e se saprà cogliere questa opportunità coinvolgendo i migliori architetti, i politici più attenti, gli imprenditori più avanzati…»
… noto il riferimento alla politica…
«…perché non è che dipende tutto dagli urbanisti e dagli architetti. Gli urbanisti e gli architetti hanno bisogno di committenti. Possono dare idee, però alla fine ci vuole una committenza che culturalmente capisce quanto la green economy non sia una parola vuota, non è soltanto mettere pannelli fotovoltaici sui tetti per produrre energia, ma una nuova visione di vita, una nuova dimensione nella quale artificio e natura si compenetrano a vicenda…»
… ecco a questo proposito, secondo lei, iniziando dai committenti, quindi amministrazioni pubbliche ecc., lo stanno capendo? A me pare che qualcosa si stia muovendo, ma vorrei sentire la sua opinione.
«Qualcosa si sta muovendo, ma con una velocità che non è paragonabile all’emergenza. Se noi pensiamo alla velocità con cui si sciolgono i ghiacci e con cui subiamo gli effetti dei cambiamenti climatici, ecco ci vorrebbe una velocità di azione… e io dico della politica, perché l’imprenditoria privata può fare la sua parte, ma la farà solo se c’è un’azione collettiva e quindi pubblica, delle amministrazioni e dei governi, che vada nella direzione di riuscire a contrastare una tendenza alla distruzione del paesaggio e dell’ambiente. Non lo si fa smettendo di costruire, ma iniziando a costruire in un modo nuovo, entro una prospettiva nuova. Io ho avuto la fortuna di incontrare committenti straordinari, come gli Antinori per esempio. Ho potuto proporre di fare un edificio completamente integrato nella terra e che si fa mangiare dalla natura e dalle vigne…»
…la cantina al Bargino (San Casciano Val di Pesa)?
«Sì, la cantina del Bargino che ha avuto una grande fortuna. Però l’effetto più importante di questo progetto è l’effetto di emulazione e la sensibilità che ha costruito nell’opinione pubblica e anche nella politica, che si è accorta che si può fare una fabbrica, si può fare sviluppo economico, e allo stesso tempo un grande omaggio all’ambiente. Questo è il tema».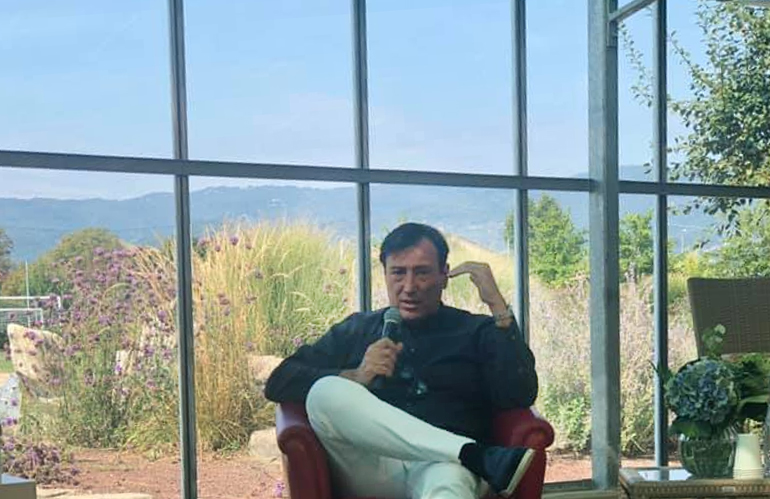
Lei però rappresenta un’eccellenza dell’architettura, ma gli architetti in generale e gli urbanisti sono pronti a questa sfida, a pensare di più al verde? Ad esempio circolano proposte come quella di anticipare i piani del verde rispetto alle edificazioni. Ecco di fronte a simili innovazioni il mondo dell’urbanistica è pronto?
«Secondo me per cultura scientifica architetti e urbanisti sono non pronti, sono prontissimi da decenni. Certo c’è ancora tanto da fare. Però si sviluppa un’offerta quando c’è una domanda. Il problema è la scarsità della domanda. Il problema è che si concepisce ancora il verde come un tema decorativo o di arredo urbano. Non si concepisce il verde come struttura integrante del nostro sistema di vita. Facciamo ancora il paragone con il digitale: dobbiamo pensare che la digitalizzazione del mondo ha cambiato i nostri usi e costumi. Ce ne rendiamo conto perché è cambiata un’epoca: non esistono più i telefoni a gettoni, esiste un apparecchio che ci portiamo dietro che ha cambiato il nostro modo di vivere. Ecco dobbiamo far sì che il verde e il rapporto fra natura e architettura cambi il nostro modo di vivere. Quando arriveremo a quel livello, potremo dire che la battaglia è vinta. Però purtroppo mentre di alcune cose non possiamo fare a meno, vedi digitalizzazione, del verde, con poca visione, si pensa di poter fare a meno. Mentre l’emergenza di oggi ci dimostra che è assolutamente impossibile farne a meno».
Ultimissima: che cosa può essere utile da parte dei vivaisti per rapportarsi a voi che progettate giardini, spazi o infrastrutture verdi?
«Posso dirlo con una battuta: non serve produrre ghiaccio per venderlo agli eschimesi, bisogna produrre ghiaccio per venderlo a chi ne ha bisogno. Direi ai vivaisti che - oltre che a piantare e fare questa operazione straordinaria di nursery, di far crescere le piante - devono veramente lavorare per un cambio culturale, collettivo e soprattutto, ripeto, di chi ha la responsabilità del governo del territorio. Quindi se io fossi un vivaista, spenderei parte dell’energia per produrre piante, parte dell’energia per costruire un cambio culturale che permetta a ciò che produco di essere utilizzato. E’ questo che deve essere fatto. Nella digitalizzazione è venuto giocoforza, da sé, è stata un’escalation virale e oggi non ne possiamo più fare a meno. Allo stesso tempo dobbiamo sensibilizzare l’opinione pubblica per farle capire che abbiamo costruito tanto su un modello veramente vecchio, quello della contrapposizione fra città e campagna e abbiamo costruito nelle campagne e ovunque. Adesso bisogna tornare a naturalizzare le città. Questo è il compito per il futuro».
Lorenzo Sandiford




