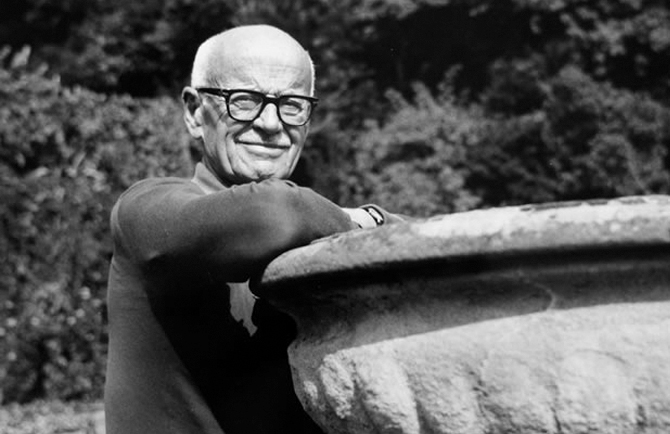Servizi
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali

Numerosi gli interventi di questa mattina all'Anteprima di Vestire il Paesaggio a Pistoia per indagare le opportunità e affermare l'importanza di un vivaismo eco-sostenibile. Il percorso da tracciare è fatto di norme di difesa integrata, sinergie con la politica, tutela di prodotti di qualità, cura del paesaggio urbano, unione fra attori del settore e un'attenta filiera del verde che parta dalla produzione e arrivi sapientemente al marketing del prodotto finale.
Apre la mattinata del seminario tecnico Rinaldo Vanni, presidente della provincia di Pistoia e sindaco del comune di Monsummano Terme, che ringrazia da subito la partnership di Flormart con Vestire il Paesaggio per la costruzione di una filiera del verde eco-sostenibile. Non meno importante è per Vanni il fatto che Pistoia sarà l'anno prossimo capitale della cultura, titolo che qui intende significare anche l'essere il centro della cultura del paesaggio. «Un evento come quello di Vestire il Paesaggio, culturale, scientifico e commerciale, rappresenta per Pistoia il fatto di essere leader a livello europeo nella produzione di piante ornamentali. Le piante sono i colori e la materia prima della costruzione e della realizzazione paesaggio.» Un paesaggio dunque che non sia effimero e imbalsamato, ma che nella sua fruibilità contribuisca a premiare il territorio e a sostenere i vivaisti nella loro azione per rafforzare l'economia e l'occupazione del settore. «Si deve investire nel verde e per la sostenibilità: le piante ornamentali possono dare il loro contributo per rendere sostenibili i nuovi insediamenti urbani, contribuendo così allo sviluppo dell'economia verde. Il vivaismo fa impresa e paesaggio producendo la materia prima».

Luca Iozzelli, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, prende poi la parola facendo i complimenti prima di tutto alla Provincia che, nonostante le difficoltà economiche, ha comunque trovato le risorse per realizzare l'anticipazione di Vestire il Paesaggio. Iozzelli ricorda come sostenibilità ed eco-compatibilità siano due parole che ricorrono spesso nei media a livello globale, ma serve ancora capire appieno il loro significato. «Eco-compatibilità, sostenibilità e biodiversità sono parole che si ripetono e appartengono al nostro immaginario collettivo, esse sono profondamente legate al futuro del nostro pianeta.» Queste parole vanno allora a contraddistinguere il territorio pistoiese e oggettivamente ne incrociano il futuro. Se Pistoia vuole mandare un messaggio chiaro sul suo ruolo di città del verde, si devono superare le divisioni interne: «Cosa che è difficile nella nostra realtà territoriale: nel patrimonio genetico dei pistoiesi ci sono i bianchi e i neri, ma si deve capire che nel mondo si entra insieme con una visione comune. La Fondazione è allora un attore importante, investe circa 12 milioni di euro l'anno in progetti di varia natura per il territorio di riferimento. Spesso siamo chiamati a fare scelte, ma questo non è il compito della Fondazione. Sono gli attori del territorio che devono fare le scelte: i privati e gli operatori economici. Noi porteremo il nostro sostegno in maniera forte ai progetti che guarderanno alla città per i prossimi venti anni e che saranno largamente condivisi.» Renato Ferretti, dirigente della Provincia di Pistoia, agronomo e direttore della manifestazione, entra poi nel merito della questione tecnica della giornata con il suo intervento su “Lo sviluppo durevole del vivaismo ornamentale”. Pistoia rappresenta una realtà che è stata ben descritta da Iozzelli, secondo Ferretti, e che possiede anche caratteristiche uniche a livello nazionale ed europeo. Si tratta infatti di una piccola area con relazioni molto strette e pressioni di carattere ambientale altrettanto significative. Questa situazione deve allora essere sfruttata a vantaggio della produzione e del settore. «La filiera produttiva è importante perché la parola vivaismo è anche il momento in cui si producono e si moltiplicano le piante da talea, da innesto e da seme. Se questo manca, è sinonimo di debolezza. Nella riproduzione della filiera Pistoia è sempre stata all'apice, negli ultimi decenni ha perso un po' di smalto, anche se lo sta recuperando pian piano. Ci si deve allora specializzare mantenendo una forte diversificazione all'interno del distretto e l'elemento di eco-sostenibilità. Altro elemento di sviluppo durevole è la diversificazione del ciclo di produzione, sia che si svolga in pieno campo, che in contenitore.» Avere la possibilità di formare piante in pieno campo consente di avere poi piante più robuste. Le piante allevate in pieno campo, prosegue Ferretti, e trapiantate ogni due, massimo tre anni acquisiscono una forza superiore. In vaso invece l'ambiente è costretto e la pianta si vizia. Produrre piante in grado di sopravvivere in ambienti ostili è allora un grande vantaggio competitivo. «Occorre creare un uso consapevole e coerente con il principio della rinnovabilità e sostenibilità. Anche nel campo del vivaismo ornamentale si deve effettuare una ricerca di specie e varietà sempre più adatte. Il mercato deve essere ampliato per utilizzare le potenzialità che ci offrono le piante. Si deve allora tenere conto anche della corteccia e del legno, non solo del colore delle foglie e dei frutti.» Vestire il paesaggio può allora dare un contributo in questo senso anche verso la comprensione della pianta quale unico prodotto capace di stoccare anidride carbonica, unico modo di minimizzare l'impatto ambientale, conclude Ferretti.

“Le tecniche di coltivazione ecocompatibili” sono poi state illustrate da Giulio Lazzerini, agronomo libero professionista, in seguito all'attività svolta presso l'Università di Firenze. Dato che il settore del vivaismo pistoiese è concentrato, questo determina delle pressioni in termini di uso delle risorse e poi di imput chimici. «Ma negli ultimi anni ho visto molti esempi di innovazioni tecnologiche che i vivaisti hanno saputo introdurre: dal classico riciclo delle acque che circoscrivono l'area del vivaio agli esempi interessanti di lotta integrata, o l'utilizzo di strati alternativi come il cocco, meno impattante rispetto alla torba. Ho visto anche validi esempi di creazioni che utilizzano i famosi scarti verdi introdotti dai vivaisti.» La valutazione della sostenibilità per l'azienda vivaistica passa dall'individuazione di indicatori, di metodi di valutazione, e di soglie di sostenibilità per la gestione ambientale aziendale. L'LCA è la metodologia utilizzata con compilazione e valutazione attraverso tutto il ciclo di vita degli elementi in ingresso e in uscita, nonché i potenziali impatti ambientali di un sistema di prodotto (Norme ISO 14040/14044-2006). Poi si dovranno definire i fattori di criticità per le diverse componenti ambientali, quali acqua, suolo e aria. Infine sarà necessario individuare gli obiettivi di miglioramento e le buone pratiche colturali capaci di ottimizzare i processi produttivi. Ultimo passaggio poi quello del monitoraggio nel tempo della gestione ambientale aziendale. Lazzerini ricorda poi che l'LCA può consentire un miglioramento delle prestazioni ambientali ed economiche di un prodotto, la definizione di un sistema di certificazione ambientale di prodotto e di processo e infine la definizione delle strategie di marketing. Le riduzioni di emissioni di CO2 possono essere infatti comunicate attraverso il Carbon Footprint, la norma ISO 14064 ½, standard internazionale per la misurazione, il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica delle emissioni e delle rimozioni dei gas serra a livello aziendale. «Il protocollo tecnico di gestione ambientale, allargato a un maggior numero di aziende serve per certificare un territorio partendo dal basso. Creando un processo partecipativo a cui le aziende possano collaborare dal punto di vista economico e commerciale», conclude Lazzerini.

Giovanni Vettori, funzionario del Servizio fitosanitario della Toscana, ha poi illustrato “La difesa integrata in vivaio”. «Da un punto di vista normativo, non si può fare difesa integrata se non si fa agricoltura integrata.» Il PAN rappresenta il braccio operativo di questo processo. Si parla allora di tutela dell'ambiente e salute del consumatore, riducendo così l'uso dei prodotti chimici di sintesi. Delle due normative esistenti sulla difesa integrata, una è obbligatoria e l'altra volontaria. La prima deriva dalla direttiva CEI128 e prevede il monitoraggio degli organismi nocivi quali parassiti e avversità, così come la previsione degli interventi necessari. La norma lascia tuttavia la possibilità di derogare a questi compiti perché non si configura sempre attivabile. Sarebbe comunque opportuno preferire i metodi biologici. Gli obblighi delle aziende agricole per la difesa integrata e illustrati da Vettori sono: conoscere e disporre direttamente dei dati meteorologici fitosanitari e dei bollettini territoriali, che influenzano l'attività dei trattamenti. È importante anche avere dati pregressi, più difficili da ritrovare ma che la Regione Toscana mette a disposizione sul sito http://agroambiente.info.arsia.toscana.it/arsia/arsia14. Il secondo livello di difesa integrata volontaria interessa marginalmente il mondo vivaistico e trova applicazioni nel PSR "Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici".

“Il ruolo del Dottore Agronomo per una produzione vivaistica sostenibile” di Francesco Bartolini (presidente dell'Ordine degli agronomi della provincia di Pistoia) ha invece focalizzato l'importanza dell'aspetto sociale della sostenibilità. Il dottor agronomo deve rivestire un ruolo a fianco delle aziende per indirizzare verso una produzione sostenibile, come descritto bene nella recente Carta dell'Agronomo, redatta in occasione di Expo. Si parla dunque di principi etici per l'esercizio di questa professione con forte valenza pubblica. «Siamo in grado di modellare il paesaggio nell'interesse generale e in un'ottica di progresso sociale. L'agronomo deve garantire azioni per il futuro, promuovere un uso a basso impatto di agrofarmaci e monitorarne l'uso.» Sostenibilità sociale è processo di certificazione ambientale, strumento importante per essere riconoscibili e mettere le aziende nelle condizioni di poter vendere prodotti di qualità. Si tratta dunque anche del riconoscimento nei mercati esteri attraverso l'uso di certificazioni, sempre più determinanti per le aziende. “Il Distretto di Pistoia verso un vivaismo di qualità sostenibile" è l'intervento finale del seminario da parte di Francesco Mati, presidente del Distretto rurale vivaistico-ornamentale pistoiese. Mati ricorda come il vivaismo nel suo cammino verso l'eco-sostenibilità debba essere sempre affiancato e supportato dalla parte politica, che possa creare una giusta tutela della produzione e sappia comunicare la qualità dei prodotti che escono da produzioni di qualità di questo tipo. Altrimenti il rischio è quello di essere superati da prodotti di scarsa qualità, magari neanche italiani, che però hanno costi di produzione minore. La globalizzazione è il mercato spietato che, secondo Mati, le aziende devono combattere con l'intervento politico di tutela. Ci deve essere un dialogo continuo fra questi due attori per creare un prodotto vivaistico di eccellenza e riconoscibile anche fuori dall'Italia, così come accade già per altri prodotti alimentari. «Va valorizzato il carattere storico del prodotto vivaistico per creare un brand frutto anche delle sinergie politiche di settore. Le opportunità a quel punto si aprono non solo a livello nazionale, ma europeo».
Anna Lazzerini
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Claudia Massi e Gianluca Chelucci hanno magistralmente analizzato alcune opere del maggior paesaggista italiano del Novecento con uno sguardo attento alla sua storia e al suo importante apprendistato per mostrarne l'eredità odierna e gettare uno sguardo al futuro, facendo tesoro del contributo artistico e intellettuale di Porcinai.
È il professor Giulio Masotti, presidente dell'Assemblea dei Soci Fondatori della Fondazione Jorio Vivarelli, a introdurre il convegno su Pietro Porcinai ricordando ai presenti perché è stata scelta Villa Storonov per questa occasione. Si tratta infatti di un importante luogo d'arte e di formazione per i giovani artisti di Pistoia: immersa nel verde, tanto importante per la cittadina, e allo stesso tempo non distante dal centro storico. Dunque un crocevia importante che spesso però viene dimenticato, come lamenta Masotti, ma che è sicuramente da valorizzare per la sua bellezza e particolarità. Questo intreccio fra arte e natura si adatta perfettamente al convegno su Porcinai, che come ricorda da subito Gianluca Chelucci, storico dell'architettura e console regionale del Touring Club italiano, ha tenuto uniti, lungo tutta la sua carriera, parte artistica e programmazione del verde e dei vivai. Le origini di Porcinai si rifanno a Villa Gamberaia a Settignano, dove nasce, figlio del giardiniere della Villa. Qui Pietro apprende subito la bellezza del lavorare la terra con fatica, tipica della grande civiltà del paesaggio toscano. Questo, spiega Chelucci, resterà un elemento della sua poetica quale imprinting a tutte le sue opere. Prosegue la storia di Porciani con il suo apprendistato “naturale” nella città di Firenze, dove conosce anche la civiltà cosmopolita. Qui frequenta la Scuola Agraria di Firenze, negli anni '20, e svolge parte del suo apprendistato per poi approdare alla città dei vivai. A Pistoia contribuisce alla creazione dei cataloghi di alcuni vivai e cresce la sua consapevolezza delle potenzialità della città e del suo verde, che, con semplicità, poteva essere trasformato in un raffinato profilo da sfruttare anche a livello comunicativo. «Oggi - lamenta Chelucci - Pistoia ha perso la possibilità di realizzare un piano urbano con poco e proprio grazie al suo magnifico verde». Porcinai comprende invece da subito la possibilità di sfruttare l'arte dei giardini nei vivai e a vantaggio della città di Pistoia. Come si legge in alcuni suoi scritti del tempo, il giardino doveva essere concepito come «intimo, confortevole, abitevole», secondo i gusti e i bisogni del vivere moderno, tenendo conto dei desideri del proprietario. Chelucci evidenzia inoltre come Porcinai sapesse approfittare di ogni strumento per pubblicizzare il suo lavoro e nel tempo si vede come egli sa adattarsi ai linguaggi contemporanei, come nel caso dell'utilizzo della grafica tipica futurista nella rappresentazione dei giardini. Tradizione e innovazione si fondono nel lavoro di Porcinai e si ispirano ai gusti europei, non solo italiani. Alcune sue creazioni, ricorda Chelucci, sono oggi a rischio come nel caso del Parco di Montaletto a Serravalle Pistoiese, realizzato nel 1937 ed oggi in vendita. Un altro grande lavoro, ancora oggi visibile, capace di esemplificare la grande innovazione che Porcinai sapeva apportare è quello dello Stabilimento di Fioricoltura Rose Barni, dove egli realizza anche il vivaio dal punto di vista organizzativo, ponendolo strategicamente vicino all'autostrada e facendo attenzione a come poteva essere percepito ad ogni distanza. Porcinai segue personalmente l'organizzazione della vendita in modo che i fiori siano consultabili con facilità. Chelucci conclude il suo intervento ricordando il grande omaggio che Giuliano Gori ha dedicato a Porcinai a Villa Celle, ispirandosi alla sua figura (come si evince chiaramente da “Omaggio a Porcinai” di Beverly Pepper).
 La seconda parte del convegno ha trattato, invece, l'eredità di Porcinai con uno sguardo al futuro ed è stata affidata a Claudia Massi, architetto che svolge attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze e ha già organizzato numerosi incontri di studio e convegni su personalità dell’Ottocento e Novecento in un più generale impegno di analisi storico-territoriale a fini di tutela e valorizzazione. Massi ci ricorda da subito il fine con cui operava Porcinai: «raggiungere l'unità e l'armonia che la Natura ci offre in tutte le sue esemplari creazioni». Un grande accento va posto poi sull'importanza che Porcinai ha, sapientemente, dato alla collaborazione con artisti, professionisti del verde e figure legate al mondo del turismo, come nel caso della collaborazione montecatinese con Pacino Pacini, consulente ATP e creatore della SAIM di Montecatini, e soprattutto con Dino Scalabrino, presidente ATP. Con quest'ultimo Porcinai ha condiviso la passione per il lavoro, per cui definisce, in una corrispondenza con lui, i progetti come propri figli. L'Accademia Dino Scalabrino è il perfetto esempio di questa concezione, i due scelgono assieme le sculture per realizzare un museo all'aperto e raccolgono da subito grandi consensi. Dalle Terme di Montecatini Terme ci spostiamo, accompagnati dalle preziose osservazioni di Claudia Massi, al Parco di Pinocchio. L'allora sindaco di Pescia, Rolando Anzilotti, commissionò vari artisti per la realizzazione di questo che era stato concepito come un parco monumentale. Nel 1956 venne inaugurato il Parco alla presenza del Presidente della Repubblica Gronchi e nel 1972 venne inaugurato il “Paese dei Balocchi”, dove lo spazio dell'analisi si dilata nel tempo e, ad ogni passo, si scoprono nuovi spazi. L'anima del progetto, oggi forse non compresa, come ricorda Massi, era quella di creare un parco monumentale, dunque non un parco di occasioni di turismo, un parco divertimenti, perché, come scriveva Anzilotti, Pinocchio è parte di ognuno di noi come conoscenza intima e profonda, impossibile da trasformare in leggerezza. Massi evidenzia poi come ci siano numerosi richiami fra il Parco di Pinocchio, novecentesco, la Villa Garzoni, settecentesca, e il borgo medievale di Collodi. Ecco allora perché non si dovrebbe intervenire in un paesaggio già così forte e caratteristico che Porcinai aveva saputo tenere assieme nella realizzazione del Parco. Ad esempio, l'Osteria del Gambero Rosso, all'interno del Parco, ci ricorda subito la tipica piazzetta di un borgo medievale o, ancora, la tettoia è come quella di una casa colonica toscana e il tavolo ci rimanda all'architettura industriale toscana. Quest'ultima, cara anche a Lorenzini, la si ritrova subito anche nella conformazione di Collodi, circondata dalle cartiere. Altro collegamento sapientemente inserito da Porcinai sono le pietre, riprese dal torrente Pescia, ma anche dal centro medievale di Collodi e dal racconto di Pinocchio, quando egli si trova a scappare da Geppetto che lo rincorre e crea un “fracasso” con i suoi piedi di legno sul lastricato. Massi infine descrive abilmente tutta la bellezza delle sculture interne al Parco di Pinocchio, come la casa della Fata: «Ho fatto l'architetto perché da piccola guardavo la casa della fata, il mio immaginario si riempiva osservando le sfaccettature dei vetri delle bottiglie del tetto».
La seconda parte del convegno ha trattato, invece, l'eredità di Porcinai con uno sguardo al futuro ed è stata affidata a Claudia Massi, architetto che svolge attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze e ha già organizzato numerosi incontri di studio e convegni su personalità dell’Ottocento e Novecento in un più generale impegno di analisi storico-territoriale a fini di tutela e valorizzazione. Massi ci ricorda da subito il fine con cui operava Porcinai: «raggiungere l'unità e l'armonia che la Natura ci offre in tutte le sue esemplari creazioni». Un grande accento va posto poi sull'importanza che Porcinai ha, sapientemente, dato alla collaborazione con artisti, professionisti del verde e figure legate al mondo del turismo, come nel caso della collaborazione montecatinese con Pacino Pacini, consulente ATP e creatore della SAIM di Montecatini, e soprattutto con Dino Scalabrino, presidente ATP. Con quest'ultimo Porcinai ha condiviso la passione per il lavoro, per cui definisce, in una corrispondenza con lui, i progetti come propri figli. L'Accademia Dino Scalabrino è il perfetto esempio di questa concezione, i due scelgono assieme le sculture per realizzare un museo all'aperto e raccolgono da subito grandi consensi. Dalle Terme di Montecatini Terme ci spostiamo, accompagnati dalle preziose osservazioni di Claudia Massi, al Parco di Pinocchio. L'allora sindaco di Pescia, Rolando Anzilotti, commissionò vari artisti per la realizzazione di questo che era stato concepito come un parco monumentale. Nel 1956 venne inaugurato il Parco alla presenza del Presidente della Repubblica Gronchi e nel 1972 venne inaugurato il “Paese dei Balocchi”, dove lo spazio dell'analisi si dilata nel tempo e, ad ogni passo, si scoprono nuovi spazi. L'anima del progetto, oggi forse non compresa, come ricorda Massi, era quella di creare un parco monumentale, dunque non un parco di occasioni di turismo, un parco divertimenti, perché, come scriveva Anzilotti, Pinocchio è parte di ognuno di noi come conoscenza intima e profonda, impossibile da trasformare in leggerezza. Massi evidenzia poi come ci siano numerosi richiami fra il Parco di Pinocchio, novecentesco, la Villa Garzoni, settecentesca, e il borgo medievale di Collodi. Ecco allora perché non si dovrebbe intervenire in un paesaggio già così forte e caratteristico che Porcinai aveva saputo tenere assieme nella realizzazione del Parco. Ad esempio, l'Osteria del Gambero Rosso, all'interno del Parco, ci ricorda subito la tipica piazzetta di un borgo medievale o, ancora, la tettoia è come quella di una casa colonica toscana e il tavolo ci rimanda all'architettura industriale toscana. Quest'ultima, cara anche a Lorenzini, la si ritrova subito anche nella conformazione di Collodi, circondata dalle cartiere. Altro collegamento sapientemente inserito da Porcinai sono le pietre, riprese dal torrente Pescia, ma anche dal centro medievale di Collodi e dal racconto di Pinocchio, quando egli si trova a scappare da Geppetto che lo rincorre e crea un “fracasso” con i suoi piedi di legno sul lastricato. Massi infine descrive abilmente tutta la bellezza delle sculture interne al Parco di Pinocchio, come la casa della Fata: «Ho fatto l'architetto perché da piccola guardavo la casa della fata, il mio immaginario si riempiva osservando le sfaccettature dei vetri delle bottiglie del tetto».
Anna Lazzerini
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Tra gli spunti dell’incontro di ieri all’Accademia sul tema “L’agricoltura scomunicata”, una web tv e un master di comunicazione su temi agricoli dei Georgofili (idee di Massimo Lucchesi), più formazione professionale dei giornalisti (Stefano Tesi), una comunicazione capace di generare conoscenza (Luca Toschi), sfidare la mentalità corrente infarcita di parole vuote e luoghi comuni come l’espressione “naturale” (Pier Francesco De Robertis).
 E’ stata poi la volta degli interventi di esponenti del giornalismo specializzato in agricoltura. Letizia Martirano, direttore dell’agenzia stampa Agrapress, ha sostenuto che «non viviamo in un momento fortunato per l’informazione, nel senso che circolano molti dati e suggestioni che non sono effettive notizie (non hanno la caratteristica della responsabilità della fonte) e ci informano più di desideri». Ma il problema è che «di fronte al susseguirsi di sciocchezze, la gente preferisce non sapere» e «si diffonde la depressione». Riguardo alla stampa generalista, pensa che si sia passati dalla «marginalità» dell’agricoltura all’opposto di adesso, con la «moda dell’agricoltura, molto grazie all’Expo»; ma «non c’è molta voglia di approfondire, per cui le notizie sono diventate letteratura e nemmeno di prim’ordine». Cristiano Spadoni, reporter di agricoltura e Internet della testata online AgroNotizie, ha sottolineato l’importanza dei nuovi mezzi attraverso cui sono veicolate le notizie, fra cui i social media. Questi mezzi, ha spiegato Spadoni, cambiano le modalità di fruizione delle notizie: «siamo noi che sempre più spesso andiamo a cercare le informazioni che ci servono invece di riceverle tramite sistemi push». Spadoni ha messo in evidenza l’importanza del «farmer journalism» (giornalismo dei contadini), che è una forma di citizen journalism significativa e «forse più basata sulle esperienze che le notizie», e del «data journalism» che permette di estrarre da enormi quantità di dati elementi di conoscenza da comunicare. Ma il sistema di verifica delle notizie, ha ammesso Spadoni, anche nel giornalismo digitale è più o meno lo stesso del giornalismo tradizionale, perché «non abbiamo i robot journalists» e si fa piuttosto uso del telefono.
E’ stata poi la volta degli interventi di esponenti del giornalismo specializzato in agricoltura. Letizia Martirano, direttore dell’agenzia stampa Agrapress, ha sostenuto che «non viviamo in un momento fortunato per l’informazione, nel senso che circolano molti dati e suggestioni che non sono effettive notizie (non hanno la caratteristica della responsabilità della fonte) e ci informano più di desideri». Ma il problema è che «di fronte al susseguirsi di sciocchezze, la gente preferisce non sapere» e «si diffonde la depressione». Riguardo alla stampa generalista, pensa che si sia passati dalla «marginalità» dell’agricoltura all’opposto di adesso, con la «moda dell’agricoltura, molto grazie all’Expo»; ma «non c’è molta voglia di approfondire, per cui le notizie sono diventate letteratura e nemmeno di prim’ordine». Cristiano Spadoni, reporter di agricoltura e Internet della testata online AgroNotizie, ha sottolineato l’importanza dei nuovi mezzi attraverso cui sono veicolate le notizie, fra cui i social media. Questi mezzi, ha spiegato Spadoni, cambiano le modalità di fruizione delle notizie: «siamo noi che sempre più spesso andiamo a cercare le informazioni che ci servono invece di riceverle tramite sistemi push». Spadoni ha messo in evidenza l’importanza del «farmer journalism» (giornalismo dei contadini), che è una forma di citizen journalism significativa e «forse più basata sulle esperienze che le notizie», e del «data journalism» che permette di estrarre da enormi quantità di dati elementi di conoscenza da comunicare. Ma il sistema di verifica delle notizie, ha ammesso Spadoni, anche nel giornalismo digitale è più o meno lo stesso del giornalismo tradizionale, perché «non abbiamo i robot journalists» e si fa piuttosto uso del telefono.Lorenzo Sandiford
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Si è tenuta ieri pomeriggio la conferenza stampa, organizzata da Cia Pistoia, per capire quale potrà essere il futuro prossimo del Centro Sperimentale per il Vivaismo pistoiese. Dopo la prima gara andata deserta, la Camera del Commercio di Pistoia pubblicherà un nuovo bando verso fine mese per vendere la sua quota, pari all’80%, con un ribasso del 10% rispetto alla cifra iniziale di € 3.260.000. Intanto una cordata di imprenditori si è fatta avanti e in sua rappresentanza Francesco Mati, presidente del Distretto Vivaistico pistoiese, esprime la volontà di innovare e rilanciare il Cespevi da qui al 2020 e oltre. Il Comune di Pistoia salverà comunque i 24 ettari di verde del Centro, anche se ribadisce l’importanza di questo per la città e il distretto. Renato Ferretti, ormai presidente dimissionario del Cespevi, lamenta mancati pagamenti da parte della Regione e problemi con l’Amministrazione pistoiese.
Alla conferenza stampa la partecipazione delle autorità e dei professionisti coinvolti è stata numerosa e sentita, come ha sottolineato Sandro Orlandini, presidente Cia Pistoia, che ha organizzato l’incontro per cercare di delineare le linee di indirizzo da adottare per il futuro del Cespevi. Orlandini parte dalla constatazione che il Centro, dopo 35 anni di storia e di successi, è oggi pressoché un bosco nonostante continui ad essere una risorsa importante grazie anche al servizio fitosanitario regionale. Quale casa del florovivaismo della Toscana, come lo ha definito il giornalista Eugenio Fagnoni, il Cespevi sembra poter avere tutte le carte in regola per proseguire la sua vita di ricerca in un’ottica di innovazione. Il presidente della Camera di Commercio di Pistoia, Stefano Morandi, ha spiegato chiaramente la situazione che ha portato alla cessione della quota, dettata non da una scelta politica, ma dalle norme che obbligano la Camera a dismettere le sue partecipazioni in società non prettamente strategiche. Morandi ci tiene a sottolineare: «I bandi non andranno avanti all’infinito, al massimo si prevede una svalutazione del 20%. Abbiamo più volte tentato di avvicinare gli operatori del settore affinché acquisissero quote del Cespevi, ma niente di concreto è stato ottenuto. Adesso l’augurio è che venga fatta un’offerta economica congrua.» Anche l’assessore regionale all’agricoltura, Marco Remaschi, è intervenuto per ricordare la necessità di ricerca e innovazione per il successo dell’agricoltura italiana in un mercato sempre più competitivo e con regole diverse in vari paesi. «Per la promozione di un settore così importante si deve ripensare il Centro a livello di rete d’impresa. Che ruolo esso può esercitare rispetto ai cambiamenti di mercato? Può essere un punto di riferimento per le aziende di settore?», così incalza Remaschi per rimarcare l’esigenza di stabilire una mission per il Cespevi. Francesco Mati, presidente del Distretto Vivaistico ornamentale, interviene affermando che di fronte ai numerosi stimoli provenienti da questa situazione, fra cui quello di Morandi e Ferretti, lui e gli imprenditori che lo affiancano non potevano non rispondere. Ecco allora che è nato un dialogo e una collaborazione fra imprenditori per immaginare uno sviluppo del Centro, come la possibilità di creare qui un distaccamento di brevetti botanici. L’intento è di far aderire il Cespevi al futuro del vivaismo da qui al 2020 e anche di più. Daniela Belliti, vicesindaco del Comune di Pistoia, ha sottolineato come il vivaismo sia per l’amministrazione un settore centrale, ma «i valorosi vivaisti che decidono di investire nel Centro non devono condannarsi alle perdite, semmai trovare un sistema di ricavi». Questi possono venire da collaborazioni con il mondo della ricerca e dell’università. «La liquidazione del Cespevi resta uno scenario da non pensare per noi. Mantenendo la dimensione di distretto, si può individuare un percorso di soluzioni che vedranno Pistoia Capitale della Cultura 2017 con una riqualificazione del verde urbano e il Cespevi quale elemento trainante di una serie di eventi.» Anche Luca Iozzelli, neo eletto presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, oggi detentrice del 20% del Centro, è intervenuto per ricordare che una fondazione di origine bancaria interviene quando esistono progetti chiari con obiettivi concreti. Soddisfatto che ci sia un primo nucleo di imprenditori pronti a progettare il futuro di quest’area, Iozzelli afferma che non c’è un prezzo congruo, ma di mercato a questo punto: se l’attività del Cespevi non regge, si dichiara il fallimento. La Fondazione crede comunque nelle potenzialità del Centro e lo ha sempre dimostrato, come ricorda Iozzelli: in particolare, nell'esercizio 2016, ha messo 200.000 euro, ma oltre a questo serve un progetto/bilancio che tenga a livello di costi e ricavi. Dal mondo della politica hanno parlato Federica Fratoni, assessore regionale all’ambiente, e Marco Niccolai, consigliere regionale, e entrambi hanno apprezzato il coinvolgimento degli imprenditori in un momento in cui la Regione non può più finanziare o effettuare operazioni di salvataggio, se non tramite i piani di sviluppo rurale e sottostando a determinate regole.
Redazione
______________________________________________________________________________________
Yesterday afternoon took place the press conference , organized by Cia Pistoia, to understand which will be the next future for the Experimental Center for Pistoia's Nursery. After the first competition that was desolate, the Chamber of Commerce of Pistoia will publish a new tender notice for the end of the month to sell its part, in the amount of 80% , with a reduction of 10% compared to the starting sum of 3.260.000 euros. Meanwhile a businessmen network step forward and in its representation Francesco Mati, president of Pistoia Nursery District, expresses his will to innovate and restart the Cespevi from now to 2020 and over. The Municipality of Pistoia will save anyway the 24 green ectars of the Center, even if reiterates the importance of this for the town and district. Renato Ferretti, already outgoing president of Cespevi, complains lack of payments from the Region and problems with the Management of Pistoia.
To the press conference the participation of authorities and professionals involved has been copious and felt, as highlighted Sandro Orlandini, president of Cia Pistoia, that organized the meeting to try outline the lines of adresses to adopt for the future of Cespevi. Orlandini starts from the verification that the Center, after 35 years of history and successes, is today almost a wood although continues to be an important resource thanks to the regional plant health service. As house of the nursery of Tuscany, like the journalist Eugenio Fragnoni defined it, the Cespevi seems aible to have all the papers in order to go on with its research life in a perspective of innovation. The president of Pistoia's Chamber of Commerce, Stefano Morandi, clearly explained the situation that has taken to the end of the sum, dictated not by a political choice, but by ruls that force the Chamber to decommiss its participation in society not essentially strategics. Morandi is interested in underlining: «The announcements won't go on for ever, at maximum it's predicted a depreciation of 20%. We tried more times to approach the sector operators so that they would acquire sum of Cespevi, but nothing concrete has been obtained. Now the wish is that another appropriate economic offer is made». Also the regional assessor to the agriculture, Marco Remaschi, partecipated to remember the necessity of research and innovation for the success of italian agriculture in a market that's always more competitive with different rules in the countries. «For the promotion of such important sector it's necessary to rethink the Center at enterprise level network. What kind of role can use compared to market changes? Can it be a reference point for the sector companies?», so Remaschi presses to notice the need to etablish a mission for Cespevi. Francesco Mati, president of the Nusery ornamental District, participates affirming that in front of many urges coming from this situation, among which the one of Morandi and Ferretti, he and the businessmen couldn't fail to answer. Here then was borned a dialogue and a collaboration between businessmen to imagine a development of the Center, as the possibility to create a detachment of botanical patents. The intent is to make the Cespevi join the future of the nursery from now to 2020 and more. Daniela Belliti, deputy mayor of Pistoia Municipality, underlined how the nursery is for menagement a central sector , but «the valian nurseymen choosing to invest must not condemn themselves to the losses, but find a incoming system». These can come by collaborations with the world of research and university. «The settlement of Cespevi remains a scenary that we must not think about. Remaining in the distric dimension, it's possible to identify a way of solutions that will see Pistoia as Capital of the Culture in 2017 with a requalification of the hurban green and the Cespevi as leading element of series of events». Also Luca Iozzelli, newly elected president of the Fondazione Cassa di Risparmio of Pistoia and Pescia, today holder of the 20% of the Center, participated to remember that a foundation by banking origin attends only when exist clear projects with real goals. Satisfied that a first unit of businessmen is ready to project the future of this area, Iozzelli affirms that there's not an appropriate cost, but a market one at this point: if the activity of Cespevi doesn't last, bankruptcy is declared. Anyway the Foundation believes in the potentiality of the Center and has always shown it, as Iozzelli remembers: particularly, in the 2016 practice, put 200.000 euros but, over this, it's necessary a project/balance taking costs and revenues. For the world of politics have spoken Federica Fratoni, regional assessor to the environment, and Marco Niccolai, regional councilman, and both admired the involvment of businessmen in a moment where the Region can't finance or do rescue operations no more, if not through the rural development plans and by putting up with rules.
Editorial staff
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali