Giardini da intervista
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
La sede del Robert Schuman Centre for Advanced Studies dell’Istituto universitario europeo di Fiesole ha un giardino significativo e non molto conosciuto. Ce lo ha illustrato Laura Bechi, del servizio Patrimonio e logistica dell’Iue, che si è soffermata sulla velocità di cambiamento dei giardini quali organismi viventi e ha ricordato che qui fu girato l’Arcidiavolo di Ettore Scola (1966), con Vittorio Gassman. [foto in home e sotto il titolo di Sailko da Wikipedia, foto dall’alto nel testo gentilmente offerte dallo Schuman Centre]
 Le tre terrazze non perfettamente allineate, la prevalenza di siepi di bosso, la piccola grotta invasa dal Ficus repens, la scalinata a due rampe finto barocca, l’emiciclo in fondo con siepi di leccio e statue chiamato “teatro della verzura”, le tuie orientali e i cedri dell’Himalaya.
Le tre terrazze non perfettamente allineate, la prevalenza di siepi di bosso, la piccola grotta invasa dal Ficus repens, la scalinata a due rampe finto barocca, l’emiciclo in fondo con siepi di leccio e statue chiamato “teatro della verzura”, le tuie orientali e i cedri dell’Himalaya. In ogni caso nel Trecento la struttura dell’immobile e dei terreni circostanti è molto diversa da quella attuale e affinché il complesso assuma, almeno nella sostanza, l’assetto di oggi bisogna aspettare il ‘400, «quando l’antico casolare – spiega Laura Bechi - viene rilevato dai Cresci, una famiglia di tintori fiorentini che avevano fatto una certa fortuna, che lo trasformano in una vera e propria villa con giardino annesso, secondo quelli che erano i canoni delle ville di campagna fiorentine. La villa rimane ai Cresci fino a più o meno la metà del ‘500, e poi comincia a passare di mano in mano». Fino al XVIII secolo la struttura esterna della villa rimane immutata, con l’eccezione del giardino che viene progressivamente trasformato in un giardino all’italiana, basato sulla simmetria e l’ordine. Questa trasformazione si completa intorno alla metà dell’800, quando la villa è in mano alla famiglia Ciacchi, che fa risistemare il giardino riducendo la parte agricola.
In ogni caso nel Trecento la struttura dell’immobile e dei terreni circostanti è molto diversa da quella attuale e affinché il complesso assuma, almeno nella sostanza, l’assetto di oggi bisogna aspettare il ‘400, «quando l’antico casolare – spiega Laura Bechi - viene rilevato dai Cresci, una famiglia di tintori fiorentini che avevano fatto una certa fortuna, che lo trasformano in una vera e propria villa con giardino annesso, secondo quelli che erano i canoni delle ville di campagna fiorentine. La villa rimane ai Cresci fino a più o meno la metà del ‘500, e poi comincia a passare di mano in mano». Fino al XVIII secolo la struttura esterna della villa rimane immutata, con l’eccezione del giardino che viene progressivamente trasformato in un giardino all’italiana, basato sulla simmetria e l’ordine. Questa trasformazione si completa intorno alla metà dell’800, quando la villa è in mano alla famiglia Ciacchi, che fa risistemare il giardino riducendo la parte agricola. Innanzi tutto, cominciando dal parterre davanti all’ingresso dell’edificio, il Ficus repens che ha invaso la piccola grotta affacciata su una parte del giardino che «ricorda molto quelli che erano i “giardini segreti” di alcune ville». Le foglie di questa pianta rampicante ornamentale, sottolinea Laura Bechi, hanno colori diversi: «le più giovani sono marroni tendenti al beige, mentre via via che crescono e invecchiano diventano più verdi». Poi c’è la «bellissima scalinata a doppia rampa, di impianto barocco (ma non barocca d’epoca, perché risalente agli anni ’30 del Novecento), con le statue e le decorazioni volute da Myron Taylor…». E più giù, verso la terrazza grande, una «siepe di cipresso che è volutamente sagomata proprio a schermare la vista», come se questa zona dovesse rimanere invisibile dalla villa. Altro particolare curioso è «il “rondò dell’amore”: un piccolo spazio semicircolare, un po’ nascosto, con delle panchine e delle piante non comuni: delle tuie orientali (Thuja), che non sono delle piante da giardino storico e non siamo riusciti a ricostruire da chi siano state piantate». Inoltre «un boschetto di leccio, che è molto caratteristico dei giardini soprattutto dell’800, e anche a Villa Salviati, per esempio, il viale delle carrozze è pieno di lecci». E ancora, in fondo al giardino, i due cedri, «che però non sono cedri del Libano, ma sono cedri dell’Himalaya, quindi una particolarità» rispetto ad altri giardini toscani.
Innanzi tutto, cominciando dal parterre davanti all’ingresso dell’edificio, il Ficus repens che ha invaso la piccola grotta affacciata su una parte del giardino che «ricorda molto quelli che erano i “giardini segreti” di alcune ville». Le foglie di questa pianta rampicante ornamentale, sottolinea Laura Bechi, hanno colori diversi: «le più giovani sono marroni tendenti al beige, mentre via via che crescono e invecchiano diventano più verdi». Poi c’è la «bellissima scalinata a doppia rampa, di impianto barocco (ma non barocca d’epoca, perché risalente agli anni ’30 del Novecento), con le statue e le decorazioni volute da Myron Taylor…». E più giù, verso la terrazza grande, una «siepe di cipresso che è volutamente sagomata proprio a schermare la vista», come se questa zona dovesse rimanere invisibile dalla villa. Altro particolare curioso è «il “rondò dell’amore”: un piccolo spazio semicircolare, un po’ nascosto, con delle panchine e delle piante non comuni: delle tuie orientali (Thuja), che non sono delle piante da giardino storico e non siamo riusciti a ricostruire da chi siano state piantate». Inoltre «un boschetto di leccio, che è molto caratteristico dei giardini soprattutto dell’800, e anche a Villa Salviati, per esempio, il viale delle carrozze è pieno di lecci». E ancora, in fondo al giardino, i due cedri, «che però non sono cedri del Libano, ma sono cedri dell’Himalaya, quindi una particolarità» rispetto ad altri giardini toscani. Infine, va ricordato il «muretto in cui fu girata, nel 1966, la scena del film l’Arcidiavolo, di Ettore Scola, in cui Vittorio Gassman tenta di sedurre Lucrezia e in cui si vede quello che noi chiamiamo il “teatro di verzura”, cioè quella specie di emiciclo in fondo di siepi di leccio». «Adesso le statue – osserva Laura Bechi – sono praticamente incastonate all’interno delle siepi, sembrano quasi coperte da esse; ma quando fu girato il film, circa 50 anni fa, erano completamente scoperte, fuori dalle siepi». Questo è un esempio molto chiaro, commenta, del fatto che «un giardino è un organismo vivente, quindi cambia in continuazione» e, a differenza di quanto accade per gli edifici e altre opere d’arte, «si modifica significativamente anche in un lasso di tempo, come 50 anni, che per un edificio è niente, mentre per un giardino equivale a secoli».
Infine, va ricordato il «muretto in cui fu girata, nel 1966, la scena del film l’Arcidiavolo, di Ettore Scola, in cui Vittorio Gassman tenta di sedurre Lucrezia e in cui si vede quello che noi chiamiamo il “teatro di verzura”, cioè quella specie di emiciclo in fondo di siepi di leccio». «Adesso le statue – osserva Laura Bechi – sono praticamente incastonate all’interno delle siepi, sembrano quasi coperte da esse; ma quando fu girato il film, circa 50 anni fa, erano completamente scoperte, fuori dalle siepi». Questo è un esempio molto chiaro, commenta, del fatto che «un giardino è un organismo vivente, quindi cambia in continuazione» e, a differenza di quanto accade per gli edifici e altre opere d’arte, «si modifica significativamente anche in un lasso di tempo, come 50 anni, che per un edificio è niente, mentre per un giardino equivale a secoli». - Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Il presidente del “Castello di Clos Lucé - Parco Leonardo da Vinci” François Saint Bris, all’Istituto Francese di Firenze per il progetto “Le vie di Leonardo”, ha presentato il suo parco culturale, che include “Il giardino di Leonardo”: un museo all’aperto sul tema della natura che riprende gli studi leonardiani di botanica, ma anche di geologia e idrodinamica. [Immagini da Wikipedia di de Serre, Als33120 e Zeist85]
 La natura imita l’arte. O meglio la natura imita l’arte che imita la natura. Può essere riassunta così l’ispirazione de’ “Le Jardin de Léonard”, ovvero “Il giardino di Leonardo”, dedicato agli studi botanici e ad altri aspetti del rapporto del genio di Vinci con la natura, nel cuore del Parco Leonardo da Vinci del Castello di Clos Lucé, ad Amboise in Francia, nella Valle della Loira. Là dove Leonardo da Vinci, invitato dal re di Francia Francesco I, trascorse gli ultimi tre anni di vita, dal 1516 al 1519, e morì.
La natura imita l’arte. O meglio la natura imita l’arte che imita la natura. Può essere riassunta così l’ispirazione de’ “Le Jardin de Léonard”, ovvero “Il giardino di Leonardo”, dedicato agli studi botanici e ad altri aspetti del rapporto del genio di Vinci con la natura, nel cuore del Parco Leonardo da Vinci del Castello di Clos Lucé, ad Amboise in Francia, nella Valle della Loira. Là dove Leonardo da Vinci, invitato dal re di Francia Francesco I, trascorse gli ultimi tre anni di vita, dal 1516 al 1519, e morì. Dopo aver ricordato che l’anno scorso il parco di Clos Lucé ha celebrato il 500° anniversario dell’arrivo di Leonardo da Vinci con tre eventi quali l’inaugurazione degli atelier restaurati del castello, dove il maestro lavorò gli ultimi tre anni fino al giorno del decesso, la mostra “Du Clos Lucé au Louvre, les trois chefs-d’oeure de Léonard de Vinci” in collaborazione con il Museo Ideale Leonardo da Vinci (vedi nostro articolo) diretto da Alessandro Vezzosi e la realizzazione del “Pont de la Corne d’Or” nel parco, François Saint Bris ha spiegato che la visita al complesso di Clos Lucé è articolata in due fasi: gli interni del castello e il parco culturale all’esterno, un percorso paesaggistico, pedagogico e ludico, sulle orme di Leonardo in uno spazio all’aperto di 7 ettari.
Dopo aver ricordato che l’anno scorso il parco di Clos Lucé ha celebrato il 500° anniversario dell’arrivo di Leonardo da Vinci con tre eventi quali l’inaugurazione degli atelier restaurati del castello, dove il maestro lavorò gli ultimi tre anni fino al giorno del decesso, la mostra “Du Clos Lucé au Louvre, les trois chefs-d’oeure de Léonard de Vinci” in collaborazione con il Museo Ideale Leonardo da Vinci (vedi nostro articolo) diretto da Alessandro Vezzosi e la realizzazione del “Pont de la Corne d’Or” nel parco, François Saint Bris ha spiegato che la visita al complesso di Clos Lucé è articolata in due fasi: gli interni del castello e il parco culturale all’esterno, un percorso paesaggistico, pedagogico e ludico, sulle orme di Leonardo in uno spazio all’aperto di 7 ettari. 
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Giorgio Galletti, rinomato architetto del paesaggio, sceglie il suo lavoro di recupero e reinvenzione del prestigioso giardino storico urbano di Firenze, diventato il parco di un noto hotel di lusso, illustrando gli elementi chiave del suo intervento sul verde. Il segreto del bravo restauratore di giardini? «Il giusto equilibrio tra conservazione e innovazione».

- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Maria Adriana Giusti, architetto e professoressa ordinaria di restauro al Politecnico di Torino, ci conduce, attraverso i suoi studi e le sue ricerche, alla scoperta della favola del Giardino Storico di Villa Garzoni, regalandoci una suggestione particolare verso quello che potrebbe essere il suo futuro prossimo, in stretta connessione con il Parco di Pinocchio e la cittadina di Collodi.
 Potremmo restare per molto tempo ad ascoltare Maria Adriana Giusti che racconta il mistero racchiuso dal Giardino di Villa Garzoni: le sue profonde conoscenze storico-artistiche si intrecciano alle sue innate doti di comunicatrice. Il nostro viaggio comincia così alla scoperta di un Giardino Storico troppo spesso incompreso, ma che rappresenta «uno straordinario complesso monumentale», come sottolinea subito Maria Adriana.
Potremmo restare per molto tempo ad ascoltare Maria Adriana Giusti che racconta il mistero racchiuso dal Giardino di Villa Garzoni: le sue profonde conoscenze storico-artistiche si intrecciano alle sue innate doti di comunicatrice. Il nostro viaggio comincia così alla scoperta di un Giardino Storico troppo spesso incompreso, ma che rappresenta «uno straordinario complesso monumentale», come sottolinea subito Maria Adriana.




- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Se siete in Inghilterra, non perdetevi il giardino del Castello di Sissinghurst, nel Kent a sud-ovest di Canterbury. Il complesso fu creato negli anni trenta da Vita Sackville-West,
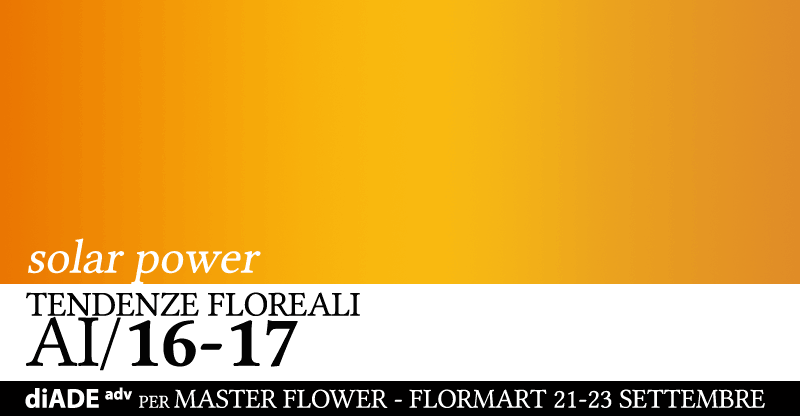 poetessa e articolista dell'Observer, per il quale curava una rubrica di giardinaggio, e dal marito Harold Nicolson, scrittore e diplomatico. Una rovina antica che la coppia ha saputo trasformare in un luogo confortevole, creandovi un giardino eccezionale con più stanze, dalle rose ai tigli, passando per alberi di noce e piante aromatiche. La bellezza perfetta di questo luogo, immaginato e creato dai due amanti del paesaggio, attira talmente tanti turisti che il loro numero deve essere limitato a 160.000 all'anno. Se siete nei dintorni, non perdetevi il mercato locale, il secondo e il quarto venerdì del mese fino a settembre, di mattina.
poetessa e articolista dell'Observer, per il quale curava una rubrica di giardinaggio, e dal marito Harold Nicolson, scrittore e diplomatico. Una rovina antica che la coppia ha saputo trasformare in un luogo confortevole, creandovi un giardino eccezionale con più stanze, dalle rose ai tigli, passando per alberi di noce e piante aromatiche. La bellezza perfetta di questo luogo, immaginato e creato dai due amanti del paesaggio, attira talmente tanti turisti che il loro numero deve essere limitato a 160.000 all'anno. Se siete nei dintorni, non perdetevi il mercato locale, il secondo e il quarto venerdì del mese fino a settembre, di mattina. 






